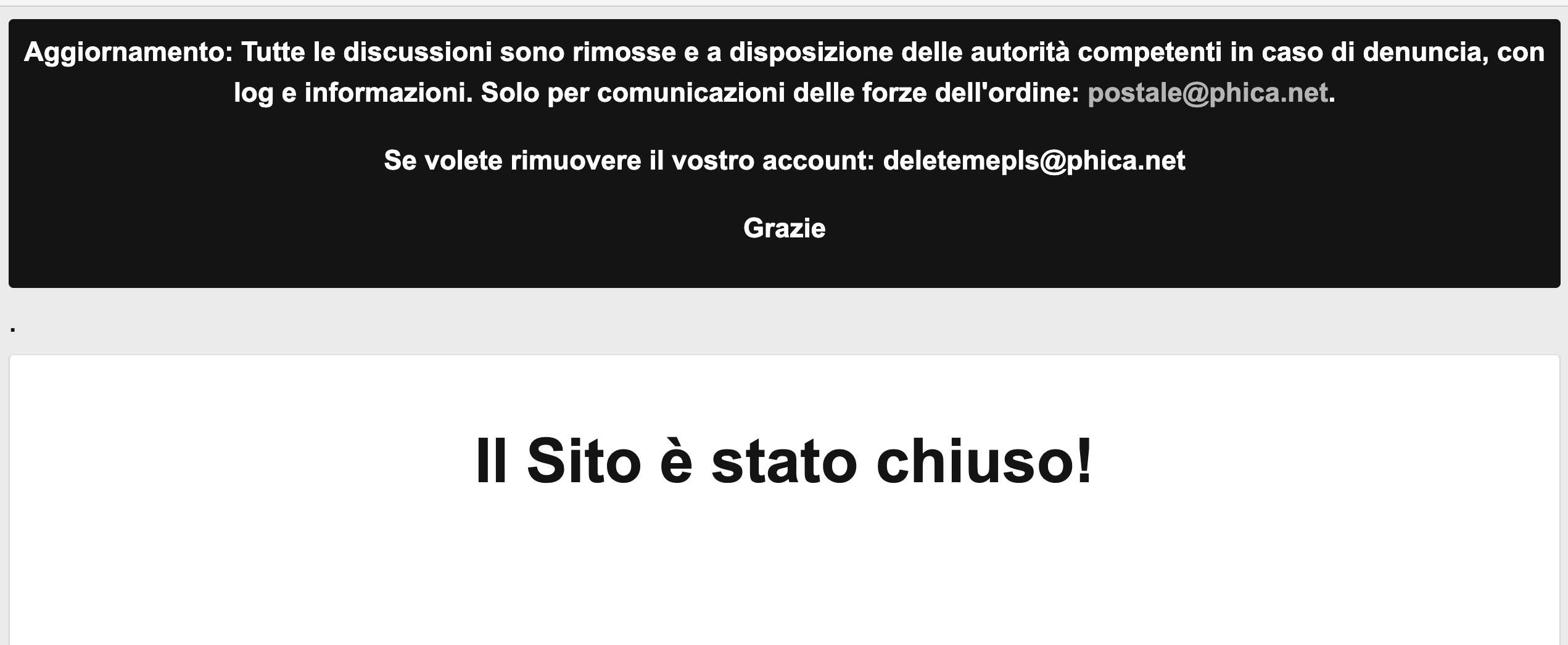Negli ultimi anni, soprattutto dopo l’escalation in Medio Oriente e le tensioni attorno alla guerra di Gaza, i termini “antisionismo” e “antisemitismo” sono stati spesso utilizzati come sinonimi, generando confusione e strumentalizzazioni politiche. Eppure, sebbene possano talvolta sovrapporsi, i due concetti hanno radici, significati e implicazioni molto diverse.
Antisemitismo: un odio millenario
L’antisemitismo è una forma di razzismo specifico, l’odio e la discriminazione contro gli ebrei in quanto tali. Le sue origini affondano nell’Europa medievale, tra accuse religiose (deicidio, usura), espulsioni di comunità, pogrom e violenze sistematiche. Nel XIX secolo, l’antisemitismo assunse anche una dimensione pseudo-scientifica, con teorie razziali che consideravano gli ebrei una “razza inferiore”.
Il culmine fu raggiunto nel XX secolo con la Shoah, lo sterminio sistematico di sei milioni di ebrei da parte della Germania nazista e dei suoi collaboratori.
Oggi, l’antisemitismo si manifesta in forme esplicite (insulti, aggressioni, vandalismi a sinagoghe e cimiteri) e in forme sottili, come stereotipi economici e culturali.
Antisionismo: critica politica, non odio etnico
Il sionismo è invece un movimento politico nato a fine XIX secolo, fondato da Theodor Herzl, che mirava alla creazione di uno Stato nazionale ebraico in risposta a secoli di persecuzioni. Nel 1948, con la fondazione dello Stato di Israele, il progetto sionista si realizzò, almeno in parte.
Da allora, il sionismo si è trasformato in un’ideologia che legittima l’esistenza e la difesa dello Stato d’Israele come patria del popolo ebraico.
L’antisionismo si definisce come l’opposizione al sionismo o a sue declinazioni politiche. Può assumere varie forme:
Critica radicale all’idea di uno Stato ebraico esclusivo, perché considerata discriminatoria verso i palestinesi.
Contestazione delle politiche israeliane, come l’occupazione dei Territori, gli insediamenti in Cisgiordania o l’assedio di Gaza.
Visione universalista, secondo cui nessun popolo dovrebbe avere uno Stato fondato su base etnico-religiosa.
In linea di principio, l’antisionismo non è antisemitismo: contestare Israele come Stato o le sue politiche non significa odiare gli ebrei in quanto tali.
Dove nasce la confusione
La confusione nasce quando l’antisionismo scivola in retoriche antisemite. Alcuni esempi:
Quando si attribuisce a “tutti gli ebrei” la responsabilità delle azioni del governo israeliano.
Quando si usano stereotipi antisemiti (cospirazioni finanziarie, lobby occulte) per attaccare Israele.
Quando si nega il diritto all’esistenza di Israele come Stato tout court, ma non si applica lo stesso metro a nessun altro Paese come ad esempio a Gaza.
In questi casi, l’antisionismo diventa un paravento per l’antisemitismo.
Il dibattito internazionale
Le istituzioni internazionali non sono unanimi. L’IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) ha adottato una definizione di antisemitismo che include “negare al popolo ebraico il diritto all’autodeterminazione”, e dunque anche forme di antisionismo. Molti intellettuali, invece, contestano questa posizione, ritenendo pericoloso equiparare critica politica e odio razziale.
In paesi come Francia, Italia, Germania e Stati Uniti, il confine è diventato terreno di battaglia politica: alcuni movimenti studenteschi filopalestinesi sono stati accusati di antisemitismo, mentre essi rivendicano il diritto alla critica contro un governo.
Perché la distinzione è cruciale
Per la comunità ebraica: confondere ogni critica a Israele con antisemitismo rischia di banalizzare il vero antisemitismo, che resta vivo e pericoloso.
Per la comunità palestinese: considerare antisemita ogni discorso critico su Israele equivale a silenziare la denuncia di violazioni dei diritti umani.
Per la democrazia: mantenere chiara la distinzione significa difendere insieme il diritto alla critica politica e la lotta contro ogni razzismo.
Antisionismo e antisemitismo quindi non sono sinonimi. Il primo è una posizione politica, criticabile o condivisibile, il secondo è un odio etnico che deve essere combattuto senza compromessi.
Il compito delle società democratiche è tracciare con chiarezza il confine: difendere le comunità ebraiche dall’odio e dalla violenza, senza criminalizzare il dissenso politico verso Israele.
In un tempo in cui le guerre e i genocidi si intrecciano con le narrazioni mediatiche, questa distinzione non è un dettaglio semantico: è la condizione per tenere insieme memoria, verità e libertà.
.png)